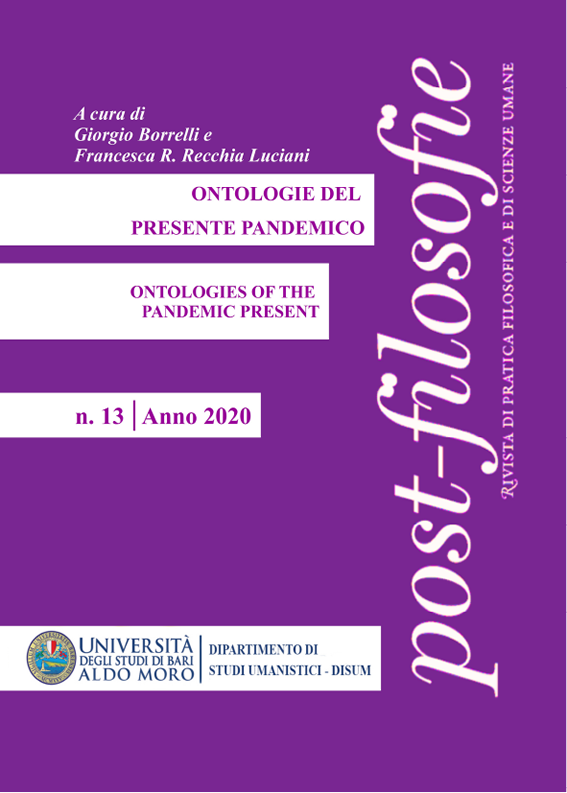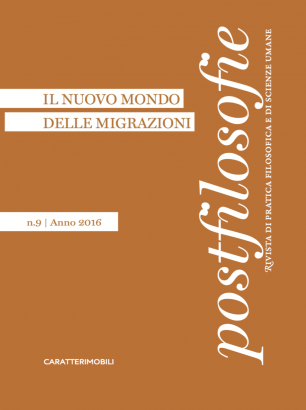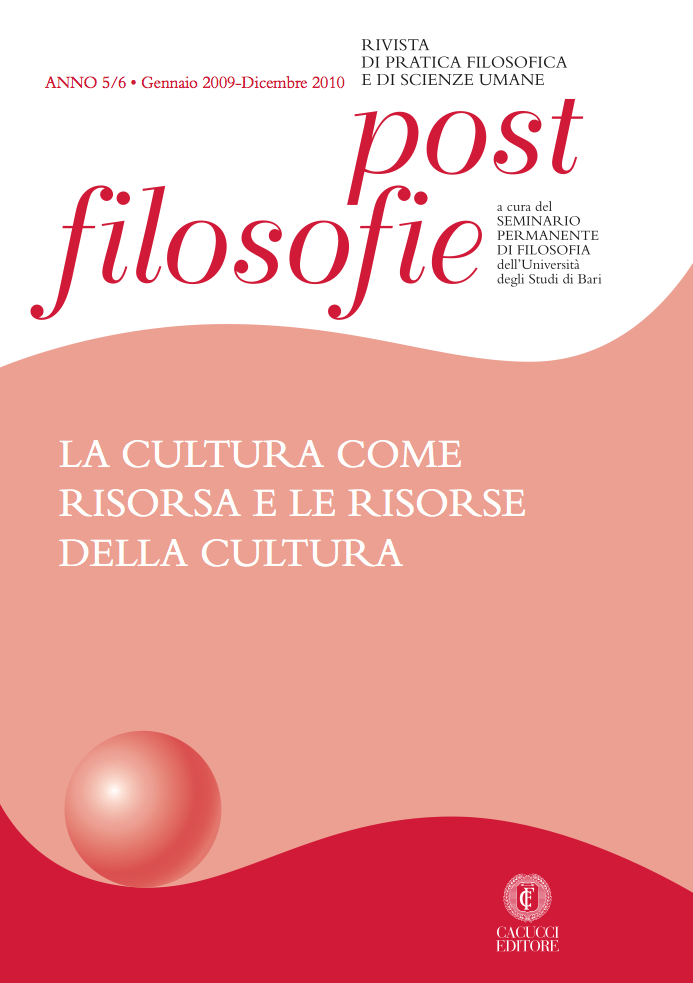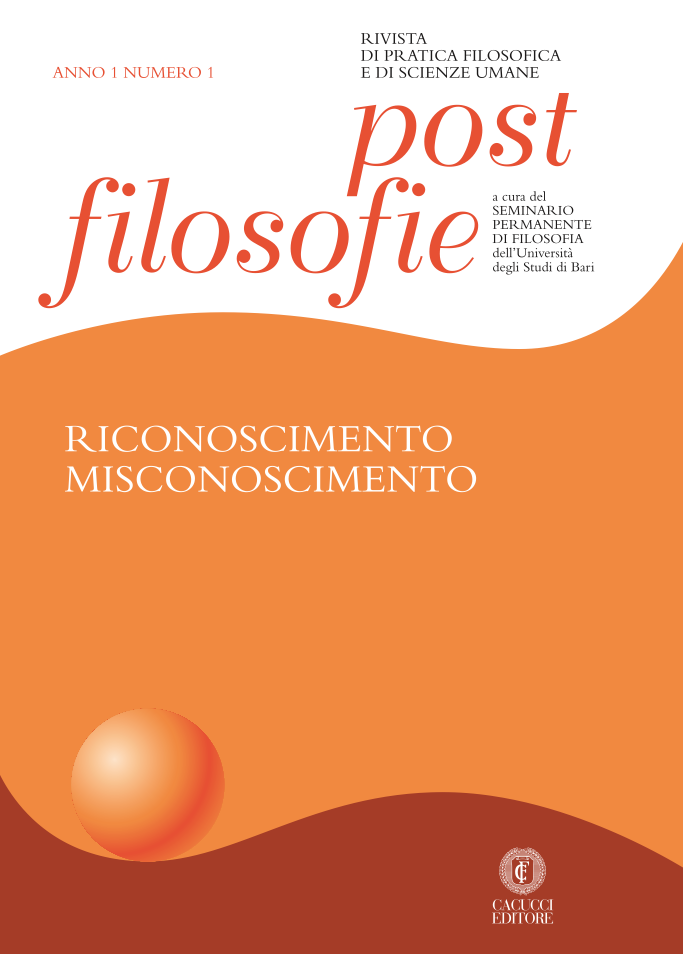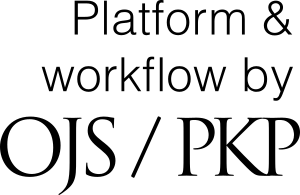Archivio
-
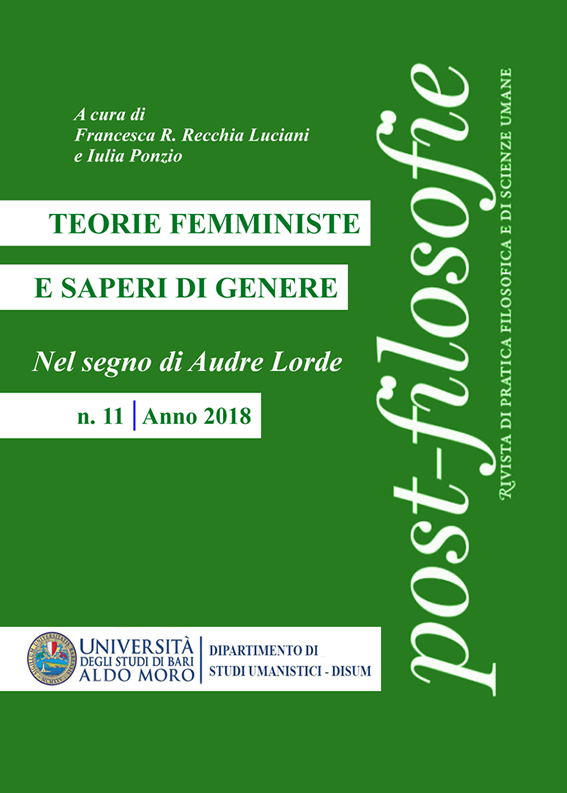
Anno 11. Numero11. Teorie femministe e saperi di genere. Nel segno di Audre Lorde
N. 11 (2018)A cura di
Francesca R. Recchia Luciani
e Iulia Ponzio -
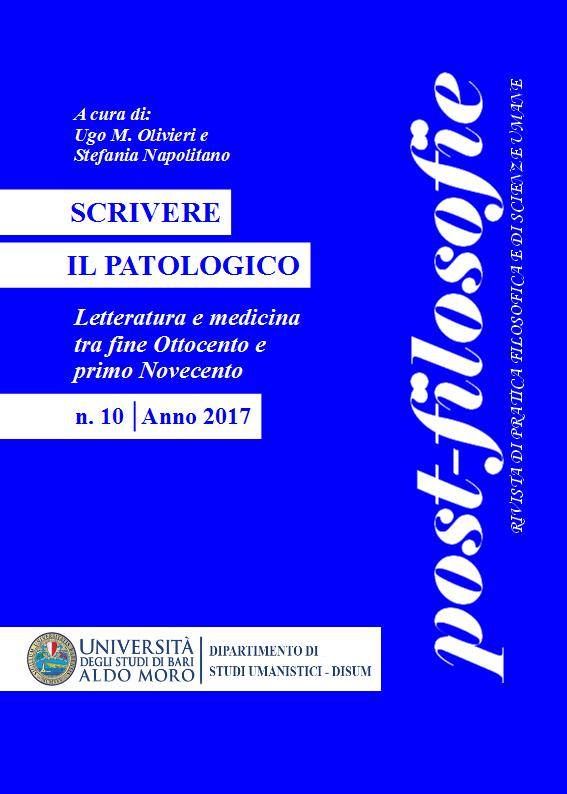
Anno 10. Numero 10. Scrivere il patologico
N. 10 (2017)Letteratura e medicina tra fine Ottocento e primo Novecento -

Anno 3. Numero 4. Riconoscimento, Dialettica e Fenomenologia. A duecent’anni dalla Fenomenologia dello Spirito di Hegel
N. 4 (2007)Il n. 4 di «Post-filosofie» è dedicato alla Fenomenologia dello spirito di Hegel, di cui nel 2007 è caduto il bicentenario anniversario della data di pubblicazione, avvenuta nell’aprile del 1807, quando Hegel, a conclusione del suo periodo jenese, s’era già trasferito a Bamberg, quale redattore della locale gazzetta.
Della singolare e complessa natura di quest’opera, che rimane, è superfluo dirlo, un testo di formazione indispensabile per chiunque voglia avere consapevolezza della filosofia e della realtà del moderno, ha iniziato col darne conto lo stesso autore. In un appunto che egli scrive a Berlino nell’autunno del 1831, cioè appena poco prima della morte, a proposito della sua intenzione di ripubblicare la Fenomenologia dello spirito, è detto: «Eigentümliche frühere Arbeit, nicht umarbeiten – auf die damalige Zeit bezüglich – in Vorrede: das abstrakte Absolute herrschte damals».1
Tale relativizzazione che lo Hegel berlinese faceva della sua prima grande opera a stampa – riferendola a un contesto di discussione teorica in cui nei primi anni dell’Ottocento dominava, da un lato, la filosofia del conoscere di Kant, con la sua scissione tra cosa in sé e coscienza, e dall’altro la dottrina della fede e del sapere come «immediatezza» di Jacobi – richiamava, dopo un venticinquennio, la presa di distanza che l’autore, rispetto alla medesima opera, aveva per altro già messo in atto subito dopo la pubblicazione, com’è testimoniato da una sua lettera a Schelling del 1° marzo 1807, in cui si duole dell’«infelice disordine» che ha dominato «sia il processo di stampa e di edizione che, in parte, la medesima composizione». La Phänomenologie des Geistes, riconosce Hegel, è solo la «prima parte» del sistema è solo l’introduzione: «non ho ancora sorpassato l’introduzione e non sono ancora giunto in mediam rem». La stessa composizione ha del resto sofferto di uno squilibrio tra le parti e il tutto. «L’approfondimento del dettaglio ha nuociuto, come ben avverto, alla veduta generale dell’insieme; il quale è per altro un tale incrociarsi di andare-e-venire, che elaborarlo meglio, fino a dargli forma più chiara e compiuta, mi sarebbe costato ancora molto tempo». Del resto, a proposito della complessità di composizione e della singolarità di quest’opera, va ricordato che essa ha due titoli, quali Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins e Phänomenologie des Geistes, di cui il secondo doveva sostituire il primo, avendoceli tramandati entrambi solo un fraintendimento nella rilegatura del volume. Ha, oltre a una «Introduzione» (Einleitung), una «Prefazione» (Vorrede), scritta solo alla fine dell’intera opera, che riprende anche temi dell’Einleitung, riformulandoli in modo nuovo. Possiede due diverse articolazioni del suo contenuto, una secondo la divisione interna al testo, un’altra secondo la divisione dell’indice. Così come mostra una singolarissima sproporzione nella distribuzione delle pagine, giacché dei sei capitoli che compongono l’opera, indicati con i numeri romani secondo la primitiva suddivisione, il primo (Die sinnliche Gewißheit) si estende nell’edizione originale per 16 pagine, il secondo (Die Wahrnehmung) per 21, il terzo (Kraft und Verstand) per 42, il quarto (Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst) per 61, il quinto (Gewißheit und Wahrheit der Vernunft) per ben 214 pagine. Tanto che Theodor Haering nel suo testo del 1938, Hegel. Sein Wollen und sein Werk, poteva avanzare la tesi che la Fenomenologia hegeliana non era per nulla un’opera concepita unitariamente, che l’iniziale progetto doveva giungere fino al capitolo sulla «Ragione» e che l’intera seconda metà dell’opera non era stata inizialmente prevista da Hegel. A testimonianza appunto, di quanto complessa e problematica sia già la sola questione della composizione e della struttura formale della Fenomenologia, del resto intrinsecamente connessa, com’è evidente, all’ordito del suo divenire concettuale. Basti pensare in tal senso alla questione della «storia», di quale sia la sua connessione con i primi capitoli attinenti alla teoria della conoscenza, di quando essa inizi propriamente nel corso dell’opera, se con la dialettica di signore e servo nel capitolo sull’«Autocoscienza» o se con il capitolo sullo «Spirito».
Orbene, rispetto a tale complessità dell’opera hegeliana e alla variegatissima gamma d’interpretazioni che di essa è stata data nel corso di due secoli, il numero di «Post-filosofie» che dedichiamo alla Fenomenologia non può che essere, evidentemente, segnato da una prospettiva storiografica ed esegetico-critica assai parziale e specifica. In continuità con i precedenti numeri della rivista, si è deciso di privilegiare il tema e il problema del «riconoscimento» e, alla luce di questa configurazione concettuale ed eticopolitica – molto dibattuta, com’è noto, nella discussione contemporanea – provare a tornare a riflettere sulla ricchezza, le sedimentazioni di senso, le difficoltà del testo hegeliano e, più in generale, della sua fortuna e della sua possibile utilizzazione attuale.
I saggi di Christian Iber, Emmanuel Renault e Roberto Finelli sono dedicati a trattare e a discutere la polisemia, filosofica, antropologica, storicoistituzionale del termine riconoscimento nell’opera hegeliana, a muovere dalla puntualizzazione e definizione di quel «concetto del riconoscimento» (Begriff des Anerkennens) che Hegel ha messo a tema nel cap. IV della Fenomenologia e che rappresenta, ancora oggi, uno dei criteri più elevati e fecondi, a nostro avviso, con cui ripensare i problemi inevadibili della riformulazione antropologica e politica cui si trova oggi di fronte l’umanità contemporanea. In quelle pagine Hegel è giunto a teorizzare il riconoscimento, non solo come testimonianza della dimensione intersoggettiva del soggetto spirituale, ma, ancor più, come luogo di una socialità, pratica e conoscitiva, la cui funzione costitutiva è quella di un reciproco «dar-libertà» e «darsilibertà», nell’intreccio stesso della relazione, tra i due soggetti in questione. Per dire cioè che il vero riconoscimento consiste in una moltiplicata realizzazione di libertà, attraverso la quale, ciascuno dei singoli trova nell’altro da sé, e reciprocamente, l’incoraggiamento e la facilitazione a mettere in atto il suo più proprio progetto di vita, la sua più irripetibile individualità, senza che questo confligga con la dimensione dell’unità tra i due, e, più in generale, dell’unità tra i molti. A patto, si aggiunge, che la produzione e l’opera di ciascun progetto individuale di vita mantengano, essi stessi, un alto profilo e un elevato contenuto d’universalità e che non ricadano in desideri e manufatti di rilievo e utilità solo individualistica.
Ma c’è da domandarsi, rispetto a tale «concetto del riconoscimento», attraverso cui Hegel ha provato a risolvere il problema di come mediare libertà dell’individuo moderno e libertà della comunità antica, quanto poi lo stesso Hegel e la stessa Fenomenologia riescano a dar conto e a realizzare, sia sul piano della pienezza dell’esistenza individuale che su quello dell’adeguatezza funzionale e storica delle istituzioni, un criterio di tale natura: in cui l’unità e la «prossimità» della relazione si attua, paradossalmente, proprio attraverso l’individuazione e la «distanza» dei suoi membri. C’è da domandarsi cioè quanto il percorso del riconoscimento, nell’intera Fenomenologia hegeliana, e della progressiva liberazione dello spirito moderno riesca effettivamente a mantenere lo sviluppo e la compresenza di entrambe queste due istanze della libertà o se, viceversa, non prevalgano soluzioni segnate da asimmetria e dal rilievo univoco della dimensione collettivoistituzionale su quella individuale e personale.
A tal fine seguono, nell’articolazione di questo numero di «Post-filosofie», i saggi di Caterina De Bortoli, Walter Jaeschke, Francesco Toto: i primi due volti ad analizzare, rispettivamente, la funzione del linguaggio nella Fenomenologia e il concetto di «sapere assoluto». Il terzo, destinato ad una singolare incursione roussoiana in campo hegeliano, motivata non tanto e non solo dalla presenza di Rousseau nella formazione del primo Hegel, quanto dalla delineazione di un paradigma su «passioni, natura e riconoscimento», il cui confronto, nella diversità, appare quanto mai utile alla comprensione e all’approfondimento critico di quello hegeliano. I saggi di Antonio Carnevale e di Paola Di Cori fanno invece riferimento al dibattito attuale su Hegel nell’area anglofona, il primo dedicato alla fortuna della Fenomenologia nella filosofia post-analitica statunitense e il secondo al rilievo di Hegel in una prospettiva culturale ed etico-politica sempre più animata dagli “studi delle donne”, dai “black studies”, dai “cultural studies”. Infine, chiude questa annata di «Post-filosofie» un saggio di Rossella Bonito Oliva sulla «libertà individuale tra diritti e norme», che, senza farsi carico di alcuna volontà conclusiva, riflette, in coerenza con gli altri saggi, sui nessi di continuità e discontinuità, di concretezza ed astrazione, che corrono ed operano tra «fondo e mondo simbolico comune» e possibili riconoscimenti individuali.
1 «lavoro propriamente giovanile, non elaborare – riferito al tempo di allora – nella Prefazione: allora dominava l’Assoluto astratto» (cfr. G. W. F. Hegel, “Phänomenologie des Geistes”, a cura di W. Bonsiepen e R. Heede, in Gesammelte Werke, Felix Meiner, Hamburg 1980, Band 9, p. 448), traduzione mia. -
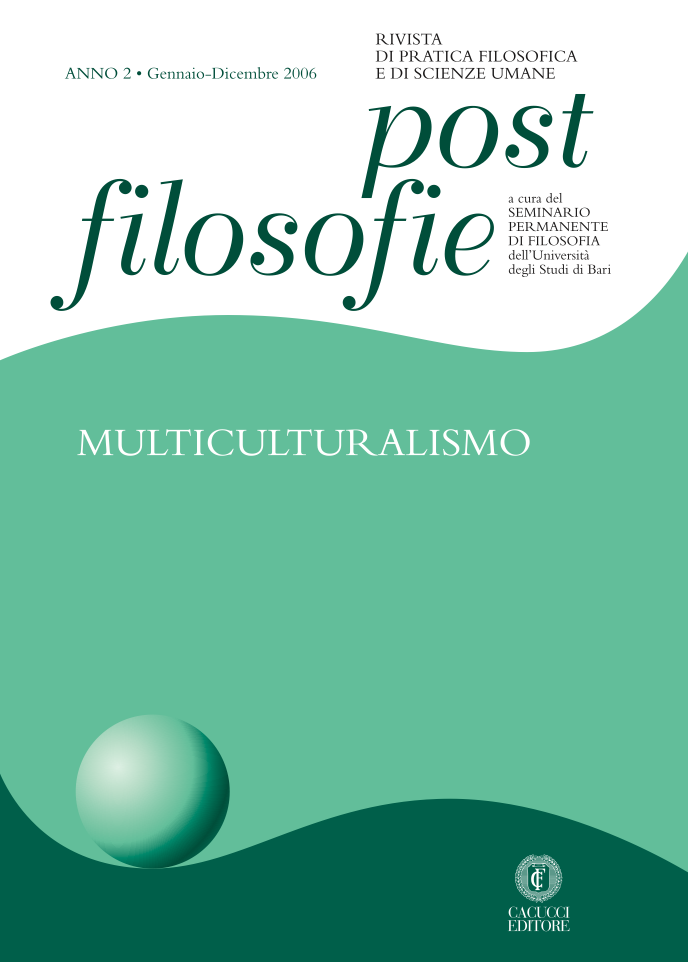
Anno 2. Numero 3. Multiculturalismo
N. 3 (2006)INTRODUZIONE
Se abbiamo scelto di dedicare il terzo numero di «Post-fi losofi e»alla problematica del multiculturalismo, non è solo perché è facilmente intuibile la sua contiguità o, meglio, intersezione con il tema del riconoscimento, che è stato al centro dei fascicoli precedenti. Ci sono anche ragioni molto più pressanti derivanti dal fatto che si tratta di una parola-chiave del lessico politico contemporaneo che racchiude, per così dire, enciclopedie fi losofi che differenti e talvolta incommensurabili, dal momento che nel linguaggio quotidiano evoca significati dissimili e rinvia ad universi simbolici opposti. Il termine “multiculturalismo”, infatti, non è un designatore rigido, ma piuttosto, come direbbe Wittgenstein, una famiglia di concetti che hanno sì tra loro numerosi tratti di rassomiglianza, ma incorporano esperienze storico-culturali e forme di vita molto differenziate. Tuttavia, accade di imbattersi in Italia, soprattutto nella pubblicistica corrente, in un uso del termine gravato di una dimensione assiologica monistica: o immediatamente positiva o intrinsecamente negativa. Diversamente da altri paesi europei come lʼInghilterra, la Francia e la Germania, il nostro paese solo in anni relativamente recenti ha conosciuto il fenomeno dellʼimmigrazione, in un primo tempo dallʼAlbania e dalle regioni balcaniche e poi soprattutto dal nord-Africa. Pertanto, solo nellʼultimo decennio si può dire che anche lʼItalia si è avviata a diventare una “società multiculturale” per la presenza di diversi gruppi di immigrati, per lo più di religione musulmana. Ma paradossalmente questo tendenziale cambiamento della composizione demografi cadella società italiana non ha signifi cato un approfondimento criticodella problematica del multiculturalismo, ma per lo più una sua utidiritto di “protocittadinanza”, cioè come “una forma di socializzazione politica nel sistema politico nazionale, che consente agli immigrati di sviluppare vincoli di fi ducia e di lealtà verso le istituzioni nazionali,e di qui come un passo verso la piena cittadinanza nazionale” (p. 139). Senza dubbio, la prospettiva dellʼintegrazione multiculturale di Kymlicka appare troppo armonicistica e poca attenta non solo alla porosità delle culture, ma anche alle diseguaglianze economiche e sociali. Ma se vogliamo sciogliere quello che Gerd Baumann chiama lʼ“enigma multiculturale”, è su questo terreno concreto che dʼora in avanti la rifl essione fi losofi ca e il lavoro delle scienze sociali dovràsempre più impegnarsi, come si evince anche dal recente dibattito che su questi stessi temi si va da tempo sviluppando in Francia. Sullʼultimo numero della rivista «Mouvements» (jan./feb. 2007) intellettuali come E. Balibar, A. Caillé, M. Chemillier-Gendreau e P. Magnette si interrogano su alcune questioni-chiave: come superare la “distorsione” di una cittadinanza vincolata alla nazionalità, su quale identità lʼEuropa dovrà costruire – se unʼEuropa-potenza in senso “schmittiano” (in cui prevarrebbe unʼidea di politica edifi cata sul rapporto amico/nemico) o in senso “habermasiano” (una potenza giuridico- normativa che guarda ad un sistema nel quale una comunità politica più larga si combina con comunità politiche più ristrette). In questo numero, che da oggi inizia ad ospitare saggi ed articoli in lingua originale per rendere la rivista più accessibile ad un pubblico cosmopolitico, offriamo alcuni materiali sul multiculturalismo che riteniamo introducano nel dibattito italiano punti di vista ancora non adeguatamente considerati come quelli di S. Benhabib, J. Raz, W. Kymlicka e, infi ne, S. M. Okin, che tratta un tema decisivo come quello del rapporto tra multiculturalismo e autodeterminazione delle donne.
Francesco Fistetti -
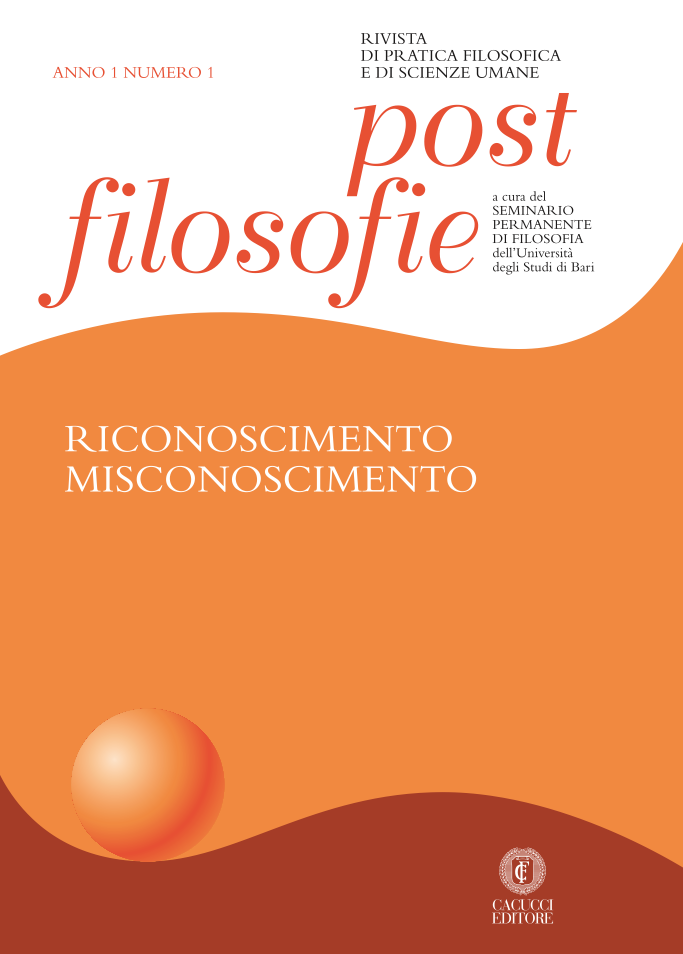
Anno 1. Numero 1. Riconoscimento/Misconoscimento
N. 1 (2005)INTRODUZIONE
Abbiamo scelto di inaugurare la rivista con una riflessione sulla problematica del riconoscimento/misconoscimento, dando conto delle posizioni più significative che nel dibattito filosofico internazionale si vanno confrontando ormai da qualche decennio. Punto di partenza per questa riflessione è il saggio di Jerome Kohn sul tema del male in Hannah Arendt, in particolare su quella forma di misconoscimento radicale del genere umano che sono state Auschwitz e Kolyma. Il Novecento è stato il secolo in cui la politica per la prima volta nella storia si è attestata sulla soglia della distruzione metodica della vita umana e della riduzione pianificata dell’uomo da “animale politico” ad essere puramente biologico. In ultima analisi, tre sono i paradigmi che in materia di riconoscimento/misconoscimento si contendono oggi la scena: il paradigma del riconoscimento vero e proprio (A. Honneth), il paradigma della giustizia (N. Fraser) e il paradigma del dono (A. Caillé e la rivista del MAUSS). Specialmente dai contributi di Alain Caillé e Christian Lazzeri e di Bryan S. Turner si comprende come il tema del riconoscimento/misconoscimento metta in discussione non solo l’intera tradizione delle scienze sociali fino alle più recenti teorie della scelta razionale (rational action theory, RAT) e degli attori in rete (analysis network theory, ANT), ma i modelli dominanti delle filosofia morale e politica, inclusa la grande tradizione giuridica occidentale da Kant a Kelsen. Sebbene da prospettive teoriche diverse, Caillé-Lazzeri e Turner concordano che sia il liberalismo politico di J. Rawls sia la teoria dell’agire comunicativo di J. Habermas appaiono del tutto insufficienti a descrivere-interpretare in termini adeguati la complessità della questione del riconoscimento/misconoscimento non solo sul piano della genesi della soggettività individuale, ma soprattutto su quello delle condizioni sociali e politiche che rendono possibile un rapporto positivo con se stessi e con gli altri. Il saggio di Honneth sviluppa il motivo dell’“autorealizzazione” dell’identità personale mostrando il paradosso che una parola d’ordine come quella della “realizzazione di sé”, in origine carica di una semantica emancipativa, si capovolga nel suo contrario, una volta che venga inscritta nella logica del mercato e in tal modo resa sinonimo di una sempre più diffusa deregolamentazione e precarizzazione dei rapporti di lavoro e dell’uso dei talenti individuali e delle competenze tecnico-scientifiche. Il paradigma del dono, nella versione di Caillé e dei teorici del MAUSS, indica una via di ricerca del tutto inedita rispetto ai paradigmi egemonici del liberalismo rawlsiano e del cosmopolitismo habermasiano, ma anche rispetto al versante filosofico contemporaneo che ha rielaborato l’antropologia maussiana del dono nella direzione che, volendo usare una formula corrente, possiamo definire dell’“impolitico” nella duplice versione da un lato di Bataille, Blanchot e Derrida in Francia e dall’altro di M. Cacciari e R. Esposito in Italia. Sulla strada aperta dal paradigma del dono sono possibili, invece, sviluppi fecondi sia di una nuova teoria critica della società che passi attraverso una teoria critica della globalizzazione, sia un ripensamento dell’universalismo dei diritti incentrato sulla vulnerabilità e sulla fragilità del corpo umano, sia infine una riconsiderazione della soggettività individuale alla luce di forme sociali o istituzioni del riconoscimento – anche in senso strettamente costituzionale – che siano intese esse stesse come beni sociali fondamentali.